IL XVII RAPPORTO PAESAGGI SOMMERSI DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA, PRESENTATO A ROMA MARTEDI 28 OTTOBRE 2025, METTE IN LUCE UN QUADRO ALLARMANTE MA NECESSARIO. ENTRO IL 2100 VASTE AREE COSTIERE ITALIANE RISCHIANO DI SCOMPARIRE SOTTO IL LIVELLO DEL MARE, IMPONENDO AL PAESE NUOVE E URGENTI STRATEGIE DI ADATTAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE
Le coste italiane tra innalzamento dei mari ed erosione
Innalzamento dei mari, erosione, inondazioni temporanee o permanenti, pressione demografica e urbanistica: la crisi climatica sta ridisegnando anche i litorali italiani. Secondo le proiezioni più attendibili, nel 2100 diverse aree del nostro Paese si troveranno sotto il livello del mare.
Le zone più vulnerabili includono l’Alto Adriatico, tratti del litorale tirrenico tra Toscana e Campania, le coste pugliesi del Gargano, le aree di Cagliari e Oristano, il Delta del Po e la Laguna di Venezia.
A rischio risultano circa la metà delle infrastrutture portuali, numerosi aeroporti, oltre il 10% delle superfici agricole e gran parte delle zone umide e lagunari italiane.
È quanto rilevato dal XVII Rapporto “Paesaggi sommersi” della Società Geografica Italiana, presentato a Palazzetto Mattei a Roma, martedì 28 ottobre, accompagnato da un ampio corredo di dati, evidenze, proiezioni e analisi.
Rapporto “Paesaggi sommersi” : impatto sulla popolazione e sull’economia costiera
Nel rapporto si stima che circa 800mila persone vivano in territori che, entro fine secolo, si troveranno al di sotto del livello medio del mare. Ovviamente, si prevede per queste comunità un processo di ricollocazione o la costruzione di difese costiere sempre più pervasive.
Del resto, sempre come affermato nel Rapporto, la fascia costiera italiana, già oggi è fortemente urbanizzata, continuando a consumare suolo nonostante divieti e regolamenti. Le politiche di tutela risultano spesso inapplicate, anche a causa dell’abusivismo edilizio e della crescente turistificazione. Se non si invertirà la rotta, l’Italia potrebbe perdere fino al 20% delle spiagge entro il 2050 e il 45% entro il 2100, con punte critiche in Sardegna, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Campania.
Gestione e pianificazione: la necessità di un cambio di paradigma
«Abbiamo trasformato la fascia costiera, un ambiente dinamico e instabile, in una linea rigida, fragile e vulnerabile», afferma Stefano Soriani, professore di Geografia economico-politica all’Università Ca’ Foscari Venezia. «È indispensabile – prosegue – un profondo ripensamento dei modelli di gestione e pianificazione costiera, riconoscendo la centralità della “questione coste” come tema strategico nazionale».
L’alternativa, secondo Filippo Celata, professore di Geografia economica e politica alla Sapienza Università di Roma, è «rinaturalizzare i litorali per sfruttare la loro capacità di adattamento». Un percorso complesso, che richiede volontà politica, risorse economiche e consenso sociale.
L’importanza del saper comunicare la crisi climatica
Durante la presentazione del Rapporto, viene posta l’attenzione anche al ruolo della comunicazione. Il modo in cui la crisi climatica viene raccontata dai media influisce sulla capacità collettiva di affrontarla. L’enfasi sull’urgenza può generare allarme, ma anche paralisi. Allo stesso tempo, la polarizzazione tra catastrofismo e negazionismo distorce il dibattito scientifico, ostacolando soluzioni condivise e basate su evidenze.
Un appello alla responsabilità collettiva
«La crisi climatica è qui per restare – sottolinea Celata – e imparare a conviverci sarà fondamentale». La sfida non è solo prevedere il futuro, ma scegliere quali scenari costieri vogliamo rendere possibili attraverso azioni concrete di adattamento e mitigazione.
«Da quasi vent’anni – aggiunge Claudio Cerreti, presidente della Società Geografica Italiana – i nostri Rapporti mirano a proporre soluzioni equilibrate, non allarmistiche, offrendo ai decisori politici strumenti per intervenire con efficacia e lungimiranza».
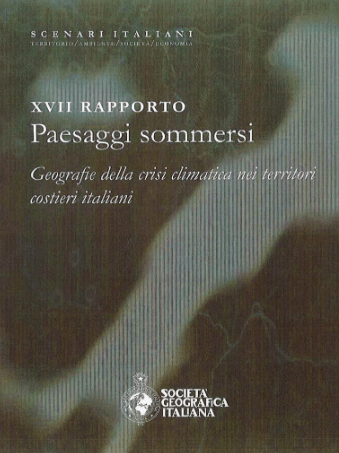
Dati chiave del Rapporto “Paesaggi sommersi”
Artificializzazione costiera: quasi un quarto del territorio entro 300 metri dalla costa è urbanizzato; picchi del 47% in Liguria e del 45% nelle Marche.
Erosione accelerata: rischio di perdita fino al 45% delle spiagge entro il 2100.
Difese costiere: barriere artificiali proteggono oltre un quarto delle coste basse, aggravando però la vulnerabilità.
Pressione turistica: i comuni costieri offrono il 57% dei posti letto turistici, con forti impatti ambientali.
Salinizzazione agricola: nel 2023 il cuneo salino ha risalito il Delta del Po per oltre 20 km, minacciando agricoltura e risorse idriche.
Aree protette vulnerabili: solo il 10% delle acque e coste italiane è tutelato, ma spesso senza piani di gestione efficaci.
Porti a rischio: oltre 2.250 km di infrastrutture portuali potrebbero subire danni gravi, compromettendo la logistica nazionale.





